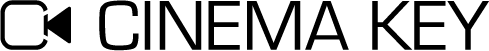People Trailer – cos’è?
July 30, 2020
“Il montaggio è il linguaggio del cinema, le inquadrature sono le sue parole.” Davide Vizzini, montatore padovano, ci racconta attraverso aneddoti e racconti personali, la magia del montaggio cinematografico.

Ciao Davide, raccontaci..fare il montatore cinematografico: cosa significa per te?
Prima di tutto significa assistere continuamente ad una magia. Subisco la fascinazione del montaggio con lo stesso entusiasmo con cui, magari da bambino, potevo stupirmi della scoperta dell’ingranaggio della pendola a casa dei nonni. Era l’emozione di accorgersi di quale magnifica complessità si cela dietro a qualcosa che in sé mi sembra (e sembrava) già stupefacente. I film che “segnavano” la mia esistenza per la gamma di stimoli che davano alla mia fantasia, si svelavano, grazie alla pratica, per quello che stava “dietro” di loro (o dentro, se vogliamo). Sia chiaro: io non sono né un nerd, né uno “pratico”, che apre gli oggetti per vedere come sono dentro. Mi sento più come uno studioso e l’università in questo è stata l’ispirazione maggiore per far diventare l’amore per il cinema un lavoro. Fare il montatore quindi vuol dire analizzare l’universo di possibilità combinatorie, studiare la più efficace e tradurre in un linguaggio emozionante la successione di immagini che compongono il film.
Lavorare come montatore: qual è la parte più complicata?
Qualche collega, in un blog o su Facebook, ha stilato una specie di decalogo delle prerogative del montatore. Una di queste dice “il montatore odia i puzzle”… per me è vero! Anche se li avessi mai amati, facendo questo lavoro il rischio di odiarli è molto alto. Montare non è poi così difficile, lo facciamo tutti i giorni quando, nella nostra testa, elaboriamo la selezione di parti della nostra memoria, delle nostre emozioni e le riportiamo in un discorso articolato ed organico. Nel montaggio l’amplificazione di questo processo elementare diventa la sua complicazione. Il montaggio è il linguaggio del cinema, le inquadrature sono le sue parole. Ci troviamo davanti a un numero più o meno ampio di opzioni e dobbiamo capire quali elementi si accostano con maggiore resa e quali sono i tempi “giusti” di ogni singola inquadratura per ottenere il giusto ritmo. Il tutto governati dalla consapevolezza che il film ha una sua “impronta”, che deve essere condivisa anche con il punto di vista di altri (in primis il regista, ma con lui il direttore della fotografia, gli attori con la loro interpretazione, e via via tutti i capi reparto che hanno lasciato un segno del proprio gusto nella realizzazione del film), quindi tesi a cercare uno stile che renda il film unico e bello. Tornando al puzzle: è come se dovessimo ricostruire un cielo totalmente azzurro di migliaia di pezzi con gli incastri ancora da sagomare! Quindi, a dispetto della disinvoltura con cui ogni montatore esperto può agire sul materiale, fare un film al montaggio è complicato fin dall’inizio. Ma è altrettanto stimolante e affascinante affrontare questa sfida creativa.
Ci racconti qualche passaggio degli ultimi progetti a cui hai lavorato?
Difficile descrivere a parole un particolare momento di una lavorazione in cui mi sono trovato a “combattere” con il materiale. Ogni passaggio o taglio è frutto di ragionamenti più o meno complessi e talvolta di influenze che arrivano dall’esterno della sala di montaggio. E’ storia nota degli interventi del produttore in tantissime realizzazioni di film famosi. Quindi spesso la cosa più complicata non è assecondare il materiale, quanto accogliere le opinioni molteplici dei primi spettatori del mio lavoro, escluso il regista con cui condivido la responsabilità delle scelte, e che talvolta hanno voce in capitolo.

Cercando di offrire un esempio che possa essere facilmente riscontrabile da chi legge, potrei raccontare due momenti della realizzazione del film Moglie e Marito : secondo sceneggiatura dopo il “prologo” ambientato in uno studio dove si fa terapia di coppia, che offre il tema del film, i protagonisti (Smutniak e Favino) si salutano fuori dal palazzo e si recano ai rispettivi luoghi di lavoro. Da qui in poi si svolgono tre scene che servono a spiegare il lavoro dei due protagonisti (un medico con un progetto rivoluzionario e un’autrice televisiva in odore di promozione per condurre un programma) e due scene che mostrano che i due sono anche genitori di due bimbi piccoli. Il tutto secondo uno svolgimento lineare e descrittivo. Il dubbio, in fase di montaggio era su come rendere “spumeggiante” l’inizio del film dopo il prologo, divertente certo, ma anche concentrato in un solo luogo per quasi tre minuti. La soluzione che si può vedere nel film è stato quello di “spremere” due delle cinque scene appena descritte, realizzando un montaggio parallelo delle due vite professionali dei protagonisti, togliendo una delle due scene di vita con i figli e sintetizzando, sulla base di una musica accattivante e ritmata, questa descrizione e la necessità di mettere i titoli di testa del film. Tutto questo senza far sembrare la cosa troppo breve, così da avere una sua ragion d’essere, ma fermando la musica e chiudendo la sequenza titoli quando si arriva alla scena in cui ci si sofferma sull’invenzione di un macchinario da parte del protagonista che è poi il motore della vicenda. Certo: non è stato così difficile montare la sequenza una volta capito come fare. Il lavoro è stato più nella ricerca della soluzione più efficace per conciliare le esigenze di sintesi, ritmo e fascinazione per uno spettatore.

L’altro momento “difficile” del film riguarda il momento del corto circuito del macchinario. Siamo sempre nelle prime fasi del film e la scena in cui tutto prende l’avvio viene raccontata con una semplice “scossa” che fa saltare i due protagonisti dalla sedia. Pur essendoci stata nella fase di ripresa una volontà di girare al fine di favorire degli inserti di computer grafica, il momento del cortocircuito è rimasto montato nello stesso modo quasi fin dalla sua prima stesura. Nella sua semplicità e “previsualizzando” nella nostra testa (mia e del regista) gli effetti speciali che sarebbero stati inseriti, il momento ci sembrava funzionare. Eppure, l’ispirazione arriva quando arriva, e solo a pochissimi giorni dal mix del film, ho immaginato di evidenziare, non tanto con un effetto speciale, ma con un semplice lavoro di editing, l’altro aspetto chiave del film: lo scambio di personalità. Quindi, nel momento del corto circuito ho esaltato “l’attimo” con una sequenza di immagini con durata variabile da 1 a 2 fotogrammi (talvolta ripetuti ma in posizioni distanti tra loro) di piccoli momenti del film in cui i protagonisti ricordano fasi della loro vita insieme. Queste inquadrature vengono usate diffusamente nel corso del film e verso il finale, ma in quel momento ho deciso di fare una sorta di “flashforward” istantaneo così da esaltare la magia di questo cortocircuito. Non meno importante un attimo dopo è stato confrontarmi con il montatore del suono per ottenere un effetto sonoro al fine di esaltare il momento. Banalmente, forse, ma con un risultato per me efficace, siamo ricorsi a un rumore di pagine che vengono fatte sfogliare velocemente. Il risultato è piaciuto al regista Simone Godano e al produttore Matteo Rovere e siamo andati al mix subito dopo. Anche qui non è stato così complicato ma è proprio in questo rischio che tutto succeda all’ultim’ora o l’angoscia che l’ispirazione non arrivi o, peggio, l’insicurezza sulla qualità del risultato (“sarà ancora perfettibile?” “Si capisce?” “E’ bello?”) che rendono difficile il nostro lavoro.
Sei entrato al Centro Sperimentale di Cinematografia quando si usava ancora la pellicola. Oggi, invece, in sala di montaggio si lavora con il digitale. Com'è cambiato il tuo lavoro in questi ultimi quindici anni?
Leggere le parole “quindici anni” mi fa venire i brividi. Ma bisogna prendere atto che moltissime cose sono cambiate, e non necessariamente in peggio. Certo, il digitale ha massacrato, più che la qualità dell’immagine, gli strumenti per la fruizione di essa. Ci muoviamo dal grande schermo (sempre più raramente) a Netflix sui nostri cellulari. Le macchine da presa più sofisticate girano con risoluzioni “digeribili” anche dal supporto più scadente, o sono facilmente “comprimibili” al fine di adattare al tipo di streaming necessario. Il digitale quindi dialoga con il digitale e la pellicola è andata in soffitta perché era lo strumento della ripresa fotografica in sequenza, della proiezione in sala con macchine che avevano un intervallo di apertura-chiusura di un otturatore a 24 fotogrammi al secondo. Con l’evoluzione tecnologica l’imponenza dell’apparato per la ripresa cinematografica classica è diventato scomodo, ingombrante. La televisione e la ripresa in video digitale ha ridotto la distanza tra il concetto nobile di cinema (appunto suggerito dall’autorità della pellicola) e la possibilità di raccontare storie con immagini realizzate a prescindere dallo strumento di ripresa. Siamo concreti: quando sono entrato al Centro Sperimentale di Cinematografia la pellicola ancora c’era, ancora si usava, ma già da anni la “rivoluzione digitale” era in corso.
La moviola per me è stata solo uno strumento di esercizio per verificare la cosiddetta “copia lavoro” dei corti che andavo a montare. Per tutto il resto c’erano già dei computer (vecchi Apple principalmente) e le enormi possibilità che il montaggio digitale offriva erano già oggetto di studio e sperimentazione sotto la guida del mio maestro Roberto Perpignani, e della mia tutor Annalisa Forgione. Il software adottato (Avid) già da tempo era in uso presso il sistema delle major (anche italiane) ed era prevedibile l’avvicendamento tecnologico, sebbene chiunque, nei primi tempi di abolizione della pellicola, nutriva una nostalgia e convinzione che la “vita” che c’è in quel supporto fisico non potesse essere mai più riprodotta nel “freddo” calcolo di un sensore ottico e di un transistor. La storia però ci insegna che il cinema rimane cinema per la grandezza dei sogni che esprime e la qualità delle storie che scrive, e così oggi accettiamo di buon grado questa rivoluzione. Quindi il mio lavoro non è cambiato poi tanto in questi quindici anni, tutto quello che posso dire è che così come i software si evolvono e con essi alcune piccole funzioni operative o possibilità creative, così io e i miei colleghi ci sentiamo stimolati ed autorizzati a fare esperimenti sempre più “audaci” o in linea con i tempi che cambiano. Ma, secondo me, se andiamo a vedere la immensa produzione audiovisiva della storia del cinema, ci accorgiamo che anche dopo la pellicola, non ci siamo inventati quasi niente di nuovo.
Tra regista e montatore che rapporto si instaura?

Questa è una domanda che mi sono fatto spesso chiedendomi come si mettono in relazione i professionisti di altre cinematografie internazionali, magari più industriali. Io posso rifarmi solo alla mia esperienza o a quella che mi raccontano i miei colleghi o mi hanno raccontato i miei maestri. Per lo più penso che si crei normalmente un rapporto simbiotico. Non posso dire che il rapporto tra montatore e regista debba essere di amicizia a tutti i costi, ma ci deve essere inevitabilmente, almeno da una delle due parti, la volontà di immedesimarsi nel modo di pensare dell’altro e cercare di entrare in sintonia con una sensibilità che non deve necessariamente essere la propria. Quando la sintonia è perfetta e i due autori in sala di montaggio si capiscono al volo e vivono in perfetta armonia, siamo di fronte a un amplificatore della possibilità di fare un gran lavoro (ma sia chiaro che si potrebbe pure rischiare di fare insieme un grosso errore). Il vero problema di una perfetta armonia è che talvolta le relazioni tra montatore e regista diventano quasi delle storie d’amore, con tutti i rischi connessi: il senso di tradimento se si lavora con qualcun altro, le litigate per far valere le proprie ragioni e cose così. Di sicuro ci deve essere un rapporto di fiducia reciproca, un dialogo sulle modalità del racconto e una buona predisposizione all’ascolto reciproco, sebbene questa prerogativa possa essere maggiormente sbilanciata a favore del montatore che deve farsi “contenitore” non solo dei contenuti girati dal regista, ma anche della personalità di quest’ultimo.
Quali problemi deve affrontare un montatore in sala di montaggio?
Il montatore è un individuo che lavora con il tempo, dentro il tempo, interpretando il tempo. Essendo il tempo un concetto astratto, sebbene quantificabile e misurabile, ecco che il problema più grande diventa imbrigliare un concetto e farne in concreto un prodotto (il film) che sulla base dell’uso del tempo contribuisce a creare ritmo ed emozioni. Il tutto cercando di rispettare delle scadenze, a breve (una serie di sequenze) o lungo termine (la chiusura del film), “paletti” creativi non da poco e che, a distanza di molto tempo, talvolta ti fanno dire: “ma che ho combinato quella volta?”. A questo problema si aggiunge quello di un coordinamento del proprio lavoro con quello di un assistente, che però, in quanto assistente, i problemi tende a risolverli, e tutti i reparti che vengono dopo di te. Pur esistendo normalmente la figura di un coordinatore di post-produzione, il montatore non si può permettere di abbandonare il film dopo la sua parte di lavoro. Quindi, una volta finito il montaggio scena, si lancerà nel controllo del lavoro dei montatori del suono seguendo il film fino al mix finale e della color correction, facendo da spalla a regista e direttore della fotografia nella scelta del look del film e nella risoluzione di problematiche eventuali che possono sorgere anche nelle ultime fasi di lavorazione. Tutto il resto, in sala di montaggio, è solo il dilemma della scelta da fare, taglio per taglio, scena dopo scena fino a realizzare il film finito.
Come montatore hai sempre lavorato nel mondo del cinema o hai provato anche quello televisivo? Tra i due, che differenze ci sono?
Alla prima parte della domanda rispondo rapidamente: ho fatto cose anche per la televisione, ma non posso parlare di un diverso modo di approcciare al montaggio televisivo rispetto a quello cinematografico perché, nei casi in cui ho lavorato per la tv le necessità di linguaggio erano affini. Cosa intendo dire? Che alla base di tutto il mio lavoro, fino ad oggi, c’è stata una richiesta da parte delle produzioni, e un’offerta da parte mia, di un lavoro sullo “storytelling” che impedisce di cogliere delle differenze tra cinema e televisione. Una serie come Zio Gianni o una trasmissione come Amore Criminale, a cui ho lavorato, sono inevitabilmente governate dall’idea di racconto e sulle regole di sceneggiatura si basano entrambe. Certo, Zio Gianni ha una forma di racconto più tradizionale di Amore Criminale che mescola interventi di personaggi reali e che raccontano la loro vicenda in diretta con ricostruzioni, ma si tratta comunque di storie. E se andiamo a vedere bene, anche in programmi con format più attuali, trovare una storia da raccontare, prendere un personaggio e vederlo crescere, costruire al montaggio gli sviluppi di una love story su un isola deserta e cose simili, si rivela necessario. Lo spettatore non può fare a meno di intravedere una “linea” da seguire in qualunque cosa guardi. Forse certi talent show sembrano essere “scollegati”, ma se guardiamo bene, la maestria del montaggio provvede a creare relazioni e sviluppi che ci riportano all’idea di racconto.
Secondo te, in quale dei due settori il montatore può esprimersi di più?
Secondo me non esiste un settore diverso dall’altro per esprimersi. La televisione richiede più velocità nel ritmo sicuramente e molta più “chiarezza”, privazione di sottointesi, di quanto non faccia il cinema che però, paradossalmente, diventa un settore dove il montatore si esprime liberamente sperimentando anche cose che terrorizzano le dirigenze televisive: il silenzio, il buio, il long take e via dicendo. Per quanto riguarda invece la spettacolarizzazione del racconto, dello show, entrambi gli ambiti, grazie alle evoluzioni tecnologiche, permettono di sbizzarirsi.
Cosa ne pensi del progetto culturale padovano Kinocchio Lab – il cinema in movimento? Come docente del laboratorio, cosa ci puoi raccontare dei giovani che vogliono inserirsi nel settore cinematografico?

Kinocchio Lab è una delle esperienze più interessanti che io abbia conosciuto nell’area della didattica per il cinema. Sebbene esistano numerosi “campi” in cui sperimentare la produzione cinematografica, dall’ideazione alla realizzazione di un progetto, solo qui e in poche altre realtà ho trovato l’intelligenza di attraversare in maniera trasversale tutti gli aspetti della comunicazione audiovisiva, offrendo non solo una didattica da parte di professionisti ospiti, ma anche dando ai partecipanti la possibilità di sperimentare la complessità delle “forme” del racconto, senza frenare l’ambizione o il tipo di strumento da utilizzare, favorendo la creatività a tutto campo fino a sfociare in linguaggi non necessariamente associabili al cinema come lo immaginiamo proiettato in una sala. Questa cosa non è da poco nel momento in cui si cerca di offrire a un giovane una possibilità di capire come realizzare i suoi sogni e anche capire i limiti che deve superare. Io credo che il cinema e tutto quello che si è portato dietro nella sua evoluzione sia un’arte che si rigenera velocemente di continuo, anche quando “si copia” dai maestri per diventare qualcuno. Non a caso si è parlato per molti movimenti culturali di onda (“vague” ad esempio): la metafora del mare mi sembra adatta. Il mare che è in movimento continuo genera le sue onde che si succedono rapidamente, e per un’onda che si infrange sulla riva ce n’è una che sta già seguendo e spingendo per esaurire tutta la sua energia “cinetica” e a sua volta lasciare spazio a una nuova onda. I giovani che vogliono inserirsi devono proprio alla loro gioventù la grande possibilità di riuscita. Hanno l’energia giusta, ma soprattutto la sensibilità del tempo che stanno vivendo che, diventando più grandi, riescono ad interpretare ma magari non a “vivere” con la stessa incoscienza ed entusiasmo. L’unica cosa che posso raccomandare però è che chiunque, giovane o meno giovane che sia, non trascuri di avere una preparazione su ciò di cui vuole parlare e sulle tecniche con cui vuole farlo. Senza conoscenza non siamo nulla, senza strumenti non possiamo raccontare storie, al massimo possiamo descrivere eventi.

Dal tuo punto di vista, com'è il panorama del cinema veneto in questo periodo?
Il cinema veneto è ricco di possibilità che in diversi casi si sono già espresse o si stanno esprimendo segnando una “corrente” autoriale molto definita. E’ cambiato il tempo dei racconti di Carlo Mazzacurati che spesso ha messo il Veneto al centro dei suoi film, ma le storie che raccontano autori come Andrea Segre o Marco Segato, per citare subito i due nomi di spicco della produzione attuale, fino ad arrivare al recentissimo Finchè c’è prosecco c’è speranza, ci dicono che anche da questo territorio possono arrivare storie universali, per tema o per genere, esportabili in tutta Italia e nel mondo (basti pensare ai temi trattati da Segre). Poi, inevitabilmente, c’è un cinema indipendente, molto indipendente, che cerca di farsi strada a spallate, sebbene talvolta io pensi che il problema non sia essere piccoli tra i grandi ma, banalmente, il non avere abbastanza umiltà per arrivare al risultato passo dopo passo. Non è simpatico dire questo pensando alla fatica che tutti facciamo per entrare o rimanere in questo ambiente, ma credo che se chi fa cinema a Nord Est cercasse di qualificare con studio e pratica il proprio percorso, magari non arriverà a fare il suo film domani, ma molto presto avrà il riconoscimento del suo talento. Forse il problema sta proprio nel Veneto stesso che stenta ad avere “film commission” trasparenti che finanzino i progetti più meritevoli e che, culturalmente, stimola l’idea del “selfmade” che trascura l’importanza della settorializzazione dei vari mestieri del cinema o, peggio, non spinge ad allargare i propri orizzonti anche accettando di cominciare fuori da questa splendida regione per poi tornarvi a girare la propria migliore storia.
Secondo la tua esperienza, che differenze trovi tra la scena del cinema indipendente veneto e quello romano?
Difficile dirlo con precisione. Dell’indipendente veneto sento una genuina, e talvolta ingenua, indipendenza anche “filosofica” dal modo di lavorare che ho visto a Roma. Se già l’Italia, nel suo fare tanta produzione indipendente, risulta essere artigianale nel suo sistema produttivo, il Veneto forse ha l’aria di essere quasi “rustico”. Ricco di ambizioni quindi, spesso orientate meglio in progetti di fruizione rapida (vedi le webseries e la comunicazione pubblicitaria o aziendale, dove andiamo forte per ragioni di committenza) che in progetti complessi che richiedono, al di là della struttura produttiva, idee e ambizione su elaborare racconti complessi, sia che si voglia fare un cinema “d’autore” (concetto superato ormai dalla qualità del lavoro di molti registi che mettono tanta ricerca in qualunque prodotto) o di genere. Roma è una città dove “fare cinema” può essere considerato mestiere alla stregua di un lavoro autonomo di qualunque tipo. In Veneto ancora si combatte per fare audiovisivi in genere, rallentando talvolta il tempo per lo studio e la ricerca formale e per la formazione di professionisti altamente specializzati sul prodotto per il cinema (o simili). Per questo so quanto sono stato fortunato dell’occasione avuta con l’ammissione al C.S.C. e per questo cerco di meritarmi quotidianamente il privilegio che mi è stato concesso e godermi l’esperienza romana, anche nelle sue contraddizioni.